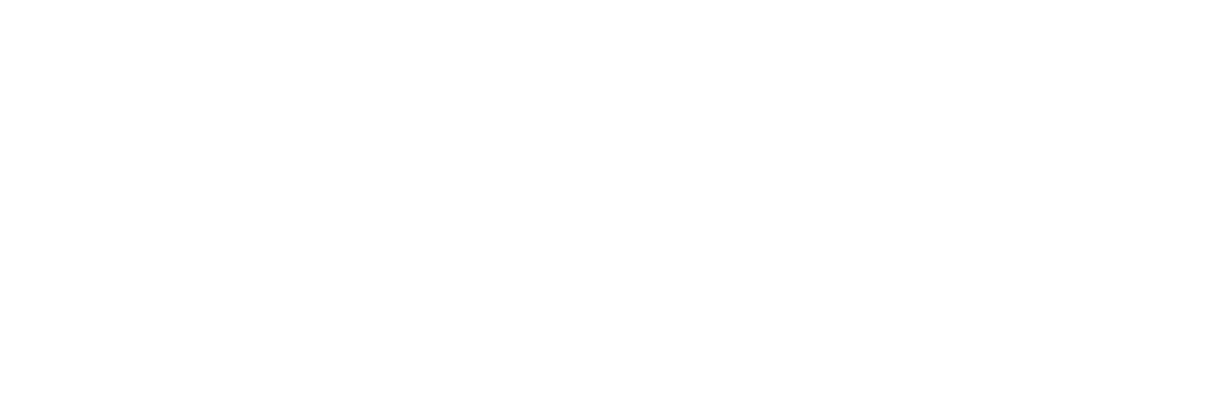Quando Alphonse de Lamartine nel 1852 pubblicò il romanzo Graziella, ambientato a Procida, non avrebbe mai immaginato che la piccola isola, punto invisibile sulla carta geografica del golfo di Napoli, sarebbe diventato un luogo conosciuto e amato, dapprima in tutta l’Europa e poi nel mondo.
Il romanziere, senza saperlo, favorì il richiamo sull’isola di cittadini europei: era la virtù dell’arte letteraria che planava sulla piccola isola marinara, già rinomata per la genialità artigianale.

Dopo Lamartine, altri scrittori, altri artisti la conobbero e l’amarono, trovando sull’isola l’ispirazione e lasciandoci pagine straordinarie. Non possiamo non ricordare Elsa Morante, che vi giunse con suo marito Alberto Moravia nel dopoguerra e qui scrisse l’Isola di Arturo.

Scrigno misterioso e magico, nonostante le sue fragilità, Procida continua a offrire i suoi aspetti antitetici che la rendono unica e attrattiva: incontaminata e arresa, timida e austera, antica e moderna, poetica e narrativa, sconvolta e raccolta.
I contrasti sociali, pur presenti, sembrano sciogliersi ed assumere quella dimensione di leggerezza che stempera l’acrimonia e la contrapposizione brutale. E sono soprattutto gli artisti che vi intravedono, come in uno specchio, il luogo segreto della propria anima, dove fioriscono nuovi poemi, nuovi romanzi, nuove pitture, nuovi film.
Massimo Troisi, che già amava l’isola, per il film Il Postino volle che essa fosse il laboratorio ideale per raccontare la storia di esilio di Pablo Neruda.
Sergio Scapagnini, produttore, e Lamberto Lambertini, regista, decidono di girare un film ispirato al periodo storico in cui è ambientato il romanzo Graziella. Portato alla Mostra di Venezia il film vince il Premio “Cinema della cultura e del dialogo” e Procida sulle cui immagini si chiude il film è ancor una volta il luogo della rinascita e della vera liberà interiore.

Procida, esempio di accoglienza e integrazione
Culla, luogo di vita e di lavoro, laboratorio per uomini e donne di ogni Paese e cultura, Procida riesce ancora a gettare ponti di dialogo, ed essere significativo esempio di integrazione e accoglienza. In un panorama italiano non sempre prodigo, 38 migranti africani rifugiati hanno ritrovato nell’isola la serenità perduta nella loro patria.
Forse è stata questa aspirazione alla dimensione di fraternità universale presente nell’isola che ha permesso al ministro Dario Franceschini il 18 gennaio 2021 di proclamare Procida Capitale della cultura italiana 2022.
Non una grande città, ma solo una piccola isola che a partire dalle proprie fragilità e ferite della storia ha aperto i suoi porticcioli all’umanità che la circonda, creando sinergie virtuose nella consapevolezza che oggi non ci si salva da soli, ma insieme.
Pasquale Lubrano Lavadera