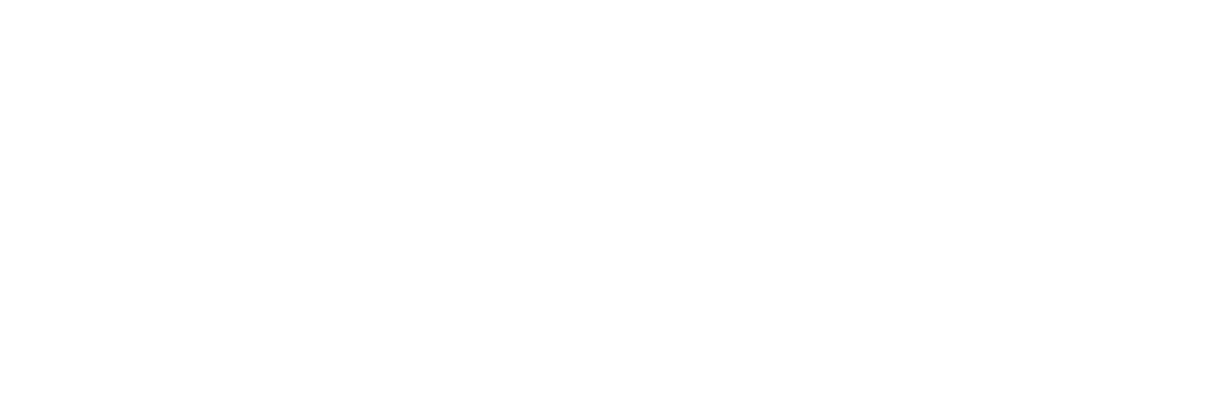Ripartiamo dagli Atti degli Apostoli. L’incontro con lo storpio è il primo dei racconti che ricamano il Libro sacro (At 3, 1-10). Sulla porta del Tempio Pietro e Giovanni incontrano un uomo, “storpio fin dalla nascita” che ogni giorno veniva lì portato per chiedere l’elemosina (3,2). Quel giorno Pietro e Giovanni si fermano dinanzi allo storpio e così scoprono che Dio non li aspetta nel Tempio ma sulla porta del Tempio! Quell’incontro cambia la vita di quell’uomo ma anche quella di Pietro e Giovanni. E apre nuovi orizzonti nella giovane comunità di Gerusalemme. Grazie a quell’incontro la Chiesa comprende che, per rispondere fedelmente alla missione ricevuta dal Signore, deve avere il coraggio di fermarsi dinanzi alla sofferenza.
La scintilla
La vita sacerdotale di don Enrico inizia con la più dura sofferenza. In quelle prime ore, che dovevano essere segnate solo dalla gioia, è costretto a piangere la morte della sorella Elisabetta. Per lei celebra la sua prima Messa. Don Enrico impara a guardare in faccia il dolore e ad affrontare la sofferenza. La durezza della vita e le difficoltà che ha incontrato negli anni successivi non hanno mai spento il suo sorriso. Anzi, ha sperimentato quella forza che solo la fede può dare.
Don Enrico, invece, aveva gli occhi aperti. E anche un cuore aperto alla grazia e pronto a compiere la volontà di Dio. Ci sono due eventi che hanno contribuito prima ad accarezzare il progetto e poi a metterlo in atto. Quando racconta la genesi della sua decisione, don Enrico insiste sulla visione di un film, “Gli uomini della Città dei Ragazzi”, avvenuta nei primi giorni del 1949. Scrive nel suo diario: «La visione del film mi accese la febbre nelle vene. Tornai a casa sconvolto. E questo turbamento mi durò per giorni».
Quel film fu solo la miccia che diede fuoco alle polveri. In realtà l’idea di fare qualcosa per i ragazzi dimorava già dentro di lui, da “molti anni”, come lui stesso confessa. Quel “nobile ideale”, così lo chiama don Enrico, appartiene intimamente alla sua vocazione e diventa un tutt’uno con la sua vita. Scrive infatti: «Ho lottato per molti giorni contro questa idea. Ma non ci sono riuscito, mi accorsi che l’idea era un altro me stesso, era tutta la vita della mia anima, per cui lottare contro l’idea significava lottare contro me stesso, rinunziare ancora a quell’idea significava rinunziare alla mia stessa vita». (11 febbraio 1949).
Quella chiamata s’innesta nella prima, è un ramo dello stesso albero, è una seconda chiamata che specifica la sua vocazione. Non rispondere a quella chiamata, non significa solo rinnegare la sua umanità ma soffocare il fuoco sacerdotale ricevuto nel giorno della sua ordinazione. È questa la sorgente nascosta della carità, la sua non è solo una risposta ad un disagio sociale ma anzitutto una scelta di fede. La carità è figlia della fede, è l’espressione matura di quella paternità che don Enrico ha ricevuto nel giorno dell’ordinazione sacerdotale.
L’incontro
«La visione di quel film fece rivivere più forte l’idea». E tuttavia, ancora non si decide, combatte con se stesso. Nel mezzo di questa lotta interiore giunge un altro segno: «Ed ecco un mattino battere alla mia porta un ragazzo di 8 anni per chiedere l’elemosina. Era lacero, i suoi piedini nudi calzavano un paio di scarpe grosse e rotte che per nulla li difendevano dal freddo. Il suo visino pallido portava i segni della sofferenza. Lo faccio entrare, divido con lui una tazza di caffè. Poi lo interrogo: di dove sei? “Di Pagani”. Hai la mamma? “Morì. Non l’ho mai conosciuta”. Hai il babbo? “Sì”. E dove sta. “Morì nell’ospedale di Nocera”. Allora adesso non ce l’hai? “No”. Con chi stai? “Con nessuno”. Dove dormi adesso che fa freddo? “In una stalla”. Bestemmi tu? “Certe volte”. Ti fai la croce la mattina? “No”. Vai in chiesa la domenica? “No”. Lo mandai via, ma pensai: quanti ragazzi in queste compassionevoli condizioni.
Quale significato è la vita per questi sventurati. Nessuno. Il passato è per essi un ricordo triste ed angoscioso; il presente squallore, l’avvenire senza nessun ideale e speranza. Eppure questi fanciulli sono le speranze dell’avvenire della società. […] Ma quale speranza possono nutrire su questi esseri che vengono alla vita senza ideali, senza educazione, senza mestiere, la Chiesa e la patria? E fu allora che innanzi a Dio e innanzi a questi fanciulli io assunsi decisamente l’impegno dell’istituzione di una Città dei ragazzi che avrebbe redento questi fanciulli e ne avrebbe fatto ottimi cittadini per il bene della Chiesa e della Patria». (11 febbraio 1949).
“Pasci le mie pecorelle”, ha detto Gesù a Pietro. Quando vede quei bambini abbandonati e senza una casa, don Enrico sente che quelle parole sono rivolte a lui. Quei bambini sono suoi, proprio come i figli generati nella carne, è il Padreterno che glieli affida. Quel ragazzino cencioso interrogava la sua coscienza di uomo e di prete, ma era Dio che lo obbligava a intervenire, quel Dio al quale aveva deciso di consacrare la propria esistenza.
L’incontro con quel ragazzino gli permette di conoscere di persona la sofferenza fisica e morale che dimora in un bambino abbandonato. Conosceva i numeri del dramma, alcuni mesi dopo parlando in una parrocchia di Pagani, disse: «Nella nostra provincia se ne contano ben diecimila di questi derelitti». Una cosa è conoscere i numeri del disagio, altra cosa è incontrare persone che vivono il disagio. Il giovane prete sentì nel profondo del cuore che quella storia lo interessava, lo coinvolgeva; e capì che doveva investire in essa gli anni della sua esistenza. Quell’incontro fu per lui il segnale decisivo, capisce che deve rompere gli indugi. Era giunto il momento di partire.
Silvio Longobardi
Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato.
- La Pasqua dei cristiani
- Il cammino per l’esame di maturità
- PUACS, a San Gerardo Maiella una giornata giubilare dedicata agli ammalati
- Il tema del secondo pellegrinaggio dei giovani a Materdomini
- Insieme – Aprile 2025