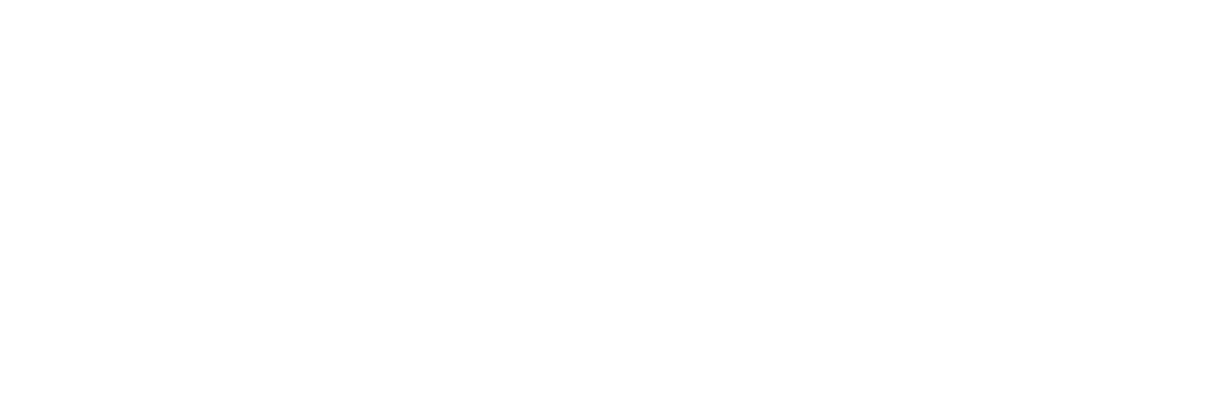Quando Gesù chiama e manda i discepoli ad annunciare la buona notizia, chiede loro di non portare nulla per il proprio sostentamento e li rassicura che «chi lavora ha diritto al suo nutrimento». La Provvidenza non manca a coloro che vanno in nome di Dio. Senza questa certezza don Enrico non avrebbe potuto buttarsi in un’avventura che, lo sapeva fin dall’inizio, era molto più grande delle sue forze.
La Provvidenza non manca ma… per riceverla occorre bussare a tante porte. Bussare con fede e umiltà. Con insistenza e senza pretese. Un progetto come quello della Città dei Ragazzi richiede una corale partecipazione e un’ampia collaborazione. Occorre anzitutto avere un terreno. Don Enrico si mette subito all’opera, condivide il suo sogno con i giovani a lui più vicini. Uno di loro offre un terreno di famiglia ma… non è adatto.
«Fu una delusione. Ritorno a casa sconfitto», scrive don Enrico nel suo Diario. Ma non si scoraggia, siamo solo all’inizio della grande avventura. Nel giro di pochi giorni si apre un’altra strada: «Penso agli Adinolfi (sic). Al mattino del 19 -1- 49 vado a casa. Parlo ad Agnese. Appoggio incondizionato, donazione certa del terreno. Risorge l’entusiasmo». Subito dopo si reca a Roma per chiedere sussidi all’ERP (Ente Ricostruzione Post Bellico).
Bussa alla porta dei potenti ma non trova accoglienza. Non rinuncia al progetto perché, ormai lo ha compreso, quel progetto non è suo, viene da Dio. E lui non vuole deludere Chi ha riposto in lui tanta fiducia. Decide allora di bussare alla porta della coscienza. Comincia dai giovani di Azione Cattolica, mostra fiducia nelle giovani generazioni e consegna loro parole che accendono il desiderio della carità. Racconta la sua esperienza, quel fuoco che sente bruciare nel suo cuore, fa capire che non basta sognare un mondo nuovo, occorre costruirlo: «Miei carissimi giovani, la costruenda città dei ragazzi si avvalorerà della vostra preziosa cooperazione. Lasciate scaturire dai cuori la forza per il bene, perché chi non sa uscire fuori di sé stesso, o non sa prodigarsi del prossimo, non è degno dell’età nostra e della professione cristiana».
L’Italia usciva stremata dalla guerra, c’era tanta povertà e tante ferite da sanare. Il prete angrese non teme di chiedere collaborazione a quelli che, come lui, erano poveri di tutto ma portavano nel cuore grandi ideali. Don Enrico è icona di una Chiesa che, ieri come oggi, lotta contro l’individualismo di chi pensa solo a sé stesso o, nel migliore dei casi, di chi pensa prima a se stesso. Il fondatore della Città dei Ragazzi chiedeva ai giovani di essere protagonisti di una storia.
Monumento di civiltà
Si rivolge anche agli adulti. In un’omelia tenuta nella chiesa del Carmine, a Pagani, pochi giorni dopo la posa della prima pietra, parla ai genitori che sanno per esperienza cosa significa prendersi cura dei figli e quanti sacrifici occorre fare per farli crescere:
«La guerra ha scavato dei vuoti immensi nella società, ma più di tutto ha scavato dei vuoti immensi nelle tenere coscienze dei fanciulli. La guerra a molti di questi sventurati ha strappato la protezione del padre, il sacrificio e le privazioni giornaliere hanno ridotto le madri in un ospedale, poi nella tomba. E questi bimbi si sono trovati soli nella vita, senza il sorriso della madre, senza la protezione del padre. Son rimasti soli, raminghi nella vita, sporchi, affamati. Noi li abbiamo visti d’inverno bussare alle nostre porte intirizziti dal freddo, per chiedere un tozzo di pane. D’estate li vediamo sporchi, affamati intristire sui marciapiedi delle nostre strade. Dalle strade apprendono tutto il male senza mai sentire una parola di bene. Domandate ad uno di questi bimbi qual è stato il loro passato, il loro presente e il loro avvenire. Essi vi risponderanno che il loro passato è un triste ed angoscioso ricordo, il presente squallore e miseria, il loro avvenire senza luce, senza speranze, senza ideale» (16 luglio 1949).
Il bene fatto da pochi sprona anche la maggioranza silenziosa a fare di più. È una legge non scritta della vita sociale. Don Enrico non appartiene alla categoria di quelli che si lamentano delle cose che non vanno. Ha visto tanti altri fare il bene con generosità e sceglie di fare altrettanto. Risponde alla chiamata di Dio ma è anche convinto, profondamente convinto, che la sua opera non solo risponde ad un’emergenza sociale ma contribuisce non poco allo sviluppo di una più matura coscienza civile e morale del nostro Paese. È convinto che la Città dei Ragazzi sarà un «monumento di amore e segnacolo di civiltà per il nostro paese. In queste parole non c’è orgoglio ma l’umile consapevolezza che la fede veste di dignità la vita umana di tutti.
Agnese Adinolfi
Nata il 4 luglio del 1926 e scomparsa il 22 maggio del 2018, Agnese Adinolfi, dottore in Giurisprudenza, fu la più stretta sostenitrice e collaboratrice del progetto di don Enrico dalla prima embrionale idea e sino alla chiusura della Città dei Ragazzi, alla quale dedicò anche dopo la morte del sacerdote ogni sua energia.
Silvio Longobardi
Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato.
- Verso la Pasqua: riconciliamoci con la Speranza
- “Ma la guerra quando arriva da noi?”
- Via Crucis diocesana ed Esercizi spirituali per i laici: insieme verso la Pasqua
- Congedo parentale
- Le novità del decreto scuola