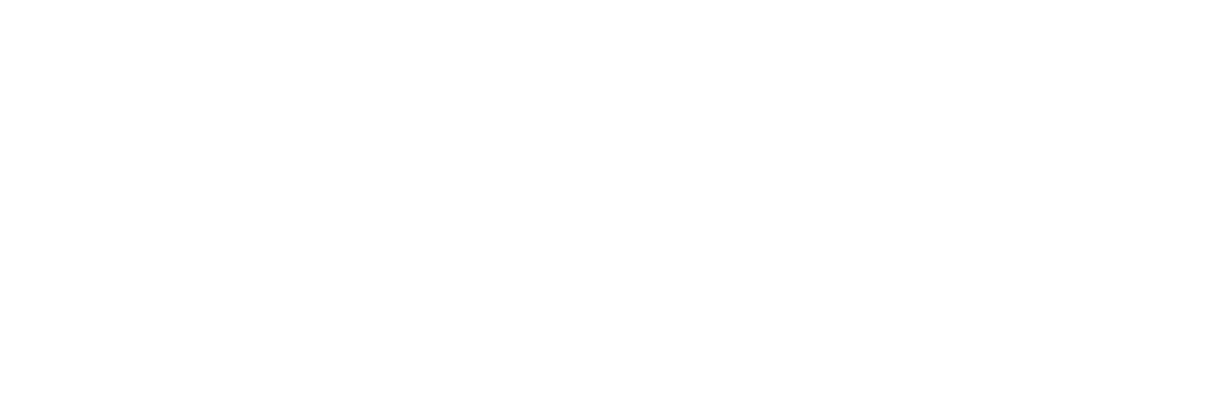«Il senso della sofferenza cristiana in don Enrico Smaldone e Alfonso Russo» è stato il tema al centro del convegno tenutosi nelle scorse settimane a Sarno.
Un incontro voluto da monsignor Giuseppe Giudice, vescovo della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, nel quarantesimo anniversario della lettera apostolica Salvifici Doloris di san Giovanni Paolo II, con l’intento di intrecciare – come ha scritto nell’invito alla Chiesa diocesana – santità e sofferenza, vita e fragilità, per dare un nuovo impulso alla pastorale della salute e al Cammino sinodale della Chiesa diocesana.
Nell’occasione abbiamo avuto modo di confrontarci con il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero per la Causa dei Santi sul valore della sofferenza cristiana.
Un atto di grande responsabilità
«Sono grato al vostro Vescovo, cui mi lega una lunga e fraterna amicizia, non soltanto per l’invito rivoltomi a commemorare il 40esimo anniversario della lettera apostolica Salvifici Doloris di san Giovanni Paolo II, ma anche per l’opportunità offertami di conoscere in questa circostanza le figure dei due Servi di Dio per i quali egli ha aperto il processo diocesano per la beatificazione e canonizzazione: il sacerdote Enrico Smaldone e il cav. Alfonso Russo», ha esordito il cardinale Semeraro, sottolineando la valenza di un gesto che richiede grande discernimento e responsabilità.
«La Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister di Giovanni Paolo II, che attualmente regola questa delicata materia – ha aggiunto – demanda proprio al vescovo diocesano il compito d’indagare sulla vita e le virtù di un fedele e sulla fama di santità che lo circonda. Quest’ultimo è un elemento davvero importante e, anzi, decisivo: un processo per la beatificazione e canonizzazione non nasce, infatti, dal desiderio di un gruppo di persone di vedere qualcuno, pure bravo ed esemplare, premiato o insignito di un titolo onorifico. La beatificazione e la canonizzazione non sono affatto questo. Per tale scopo si può fare dell’altro, come l’intitolazione di una via o una piazza, un monumento, una biografia».
La dichiarazione ufficiale della santità da parte della Chiesa è cosa ben più rilevante, che deve essere sapientemente vagliata e distinta dalla buona reputazione, dalla pubblica considerazione, dalla notorietà sociale e culturale. «Parlando di Nunzio Sulprizio, san Poalo VI disse: “Un beato e un santo devono rappresentare uno specchio per conoscere noi stessi” e anche una provocazione per una domanda personale: Se l’ha fatto lui, non potrò farlo anch’io? Questo è l’auspicio che monsignor Giudice, con grande cura, ha voluto tradurre nell’avvio dei due processi», ha spiegato.
La santità nel mondo contemporaneo
«Mentre leggevo i tratti biografici dei Servi di Dio Enrico Smaldone e Alfonso Russo, mi tornava in mente l’espressione di papa Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate», ha continuato il Cardinale, «là dove il Pontefice parla della santità della “porta accanto”, di coloro che vivono vicino a noi e sono riflesso della presenza di Dio, una santità diffusa e paziente, come quella dei genitori che crescono con amore i loro figli, degli uomini e delle donne che lavorano per portare il pane a casa, dei malati, delle religiose anziane che continuano a sorridere».
L’immagine scelta come icona del convegno, una riproduzione del Buon Samaritano di Vincent van Gogh, è stata ripresa da Semeraro per simboleggiare il senso dell’aiuto e della carità cristiana: «Per essere come il Buon Samaritano – ha detto – dobbiamo farci carico, con il cuore e con la vita, della sofferenza dell’altro».
Il Cardinale ha osservato come questo dipinto sia l’ultimo dell’artista, in un momento in cui anche van Gogh sperimentava una grande sofferenza interiore. «Ci invita a prendere su di noi le ferite di chi ci sta accanto, con pazienza e compassione, esattamente come hanno fatto don Enrico Smaldone e Alfonso Russo, le cui opere restano come segni vivi di una santità concreta».
Poveri, ma capaci di arricchire molti
«I due Servi di Dio che oggi ricordiamo non erano potenti e ricchi; erano poveri e hanno vissuto secondo quello che scrive san Paolo: “Afflitti, ma sempre lieti; poveri, ma capaci di arricchire molti” (2Cor 6,10)», ha evidenziato il Cardinale. Questa affermazione, ha osservato, risulta «agli antipodi della mentalità mondana, che apprezza solo chi è ricco e potente». Ha citato poi san Paolo VI e la Populorum Progressio, che già nel 1967 metteva in luce il divario tra ricchi e poveri, oggi sempre più accentuato, come emerge dai dati della Banca d’Italia: «Cristo, da ricco che era, si è fatto povero perché noi diventassimo ricchi della sua povertà. Nella sofferenza e nell’umiltà si trova una fonte inesauribile di ricchezza spirituale e di solidarietà».
È giunto così al cuore dell’incontro, al tema che gli è stato assegnato: «Giovanni Paolo II scrisse la sua lettera apostolica Salvifici Doloris per analizzare la tematica del dolore che, quando è vissuto dall’essere umano, acquista il nome di sofferenza – ha detto –. Questa, poi, sussiste in due forme: quella fisica e quella morale. L’uomo, infatti, non subisce semplicemente il dolore; egli soffre consapevolmente e s’interroga riguardo alla sua sofferenza: se ne domanda il perché, cioè per quale causa e per quale fine. È una domanda che riguarda non solo l’origine, ma pure la finalità della sofferenza». La risposta definitiva a questa domanda fondamentale è offerta da Cristo crocifisso e risorto. Egli non è solo Redentore attraverso la sofferenza, ma pure Redentore della sofferenza.
San Giovanni Paolo II, oltre a lasciare un insegnamento sul valore della sofferenza, ci ha offerto una vera e propria testimonianza, specialmente negli anni finali della sua vita. «Possiamo rileggerla nel suo ultimo libro, Memoria e Identità» ha ricordato il Cardinale, citando anche le parole che Benedetto XVI volle rivolgere al suo predecessore durante il primo discorso alla Curia Romana, il 22 dicembre 2005. «Giovanni Paolo II – disse papa Ratzinger – ci dice che la sofferenza di Dio crocifisso non è soltanto una forma di sofferenza accanto alle altre… Cristo, soffrendo per tutti noi, ha conferito un nuovo senso alla sofferenza, l’ha introdotta in una nuova dimensione, in un nuovo ordine: quello dell’amore». L’esempio di Giovanni Paolo II, quindi, invita a guardare alla sofferenza con gli occhi della speranza cristiana, accettando che, pur nella fragilità, vi è una promessa di salvezza.
Testimoni di speranza
L’incontro si è poi focalizzato sul significato del prossimo anno giubilare voluto da papa Francesco e dedicato alla speranza, virtù che – ha spiegato Semeraro – «nasce dall’amore e si fonda sull’amore che scaturisce dal Cuore di Gesù trafitto sulla croce».
La speranza non è infatti solo una virtù personale, ma «è sempre condivisa», come ben testimoniano le opere dei due Servi di Dio. «Alfonso Russo, fondatore della Pia Unione Ammalati Cristo Salvezza, ha indicato con chiarezza la sorgente della guarigione: Cristo; e don Enrico Smaldone per prendersi cura dei ragazzi abbandonati e rimasti orfani ha scelto il titolo di Città dei Ragazzi. La parola città – così la spiegava Isidoro di Siviglia nelle sue Etimologie – indica l’incontro delle vite di molti, la città raccoglie e salva le vite di molti. Con queste iniziative i due Servi di Dio hanno dato speranza e testimoniato il valore della sofferenza accettata e condivisa».
La conclusione di monsignor Giudice
A chiusura del convegno, monsignor Giudice ha richiamato il senso di comunità cristiana che si prende cura dell’altro, ricordando che «le vite dei santi sono scritte con il pennello della Croce», sottolineando la necessità di essere, in ogni contesto, testimoni della carità. «Ci sono tante sofferenze – ha detto -, a volte si vedono, altre volte sono nascoste nell’animo, ci sono delle rughe che non riusciamo a guardare. Proviamo ad accarezzarle, saremo anche noi buoni samaritani».
Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato.
- Civiltà della Speranza: l’inno diocesano per il Giubileo 2025
- Sant’Alfonso Maria Fusco: è festa ad Angri e nel mondo
- Salvatore Di Salvo presenta “La comunicazione cristiana nei social”
- Un incontro che cambia la vita
- Cos’è l’indulgenza plenaria e come si ottiene?